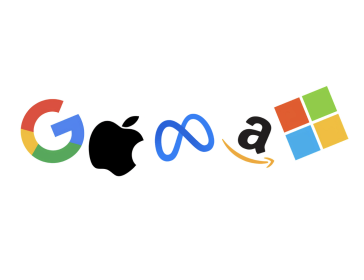Secondo l’ultima rilevazione Istat, su 35,3 milioni di abitazioni, 9,6 non sono utilizzate (il 27.2%). La presenza di abitazioni non occupate permanentemente prevale nelle aree montane e nei comuni più distanti dai servizi essenziali.
Le aree interne non solo si spopolano, ma lasciano in stato di abbandono centinaia di migliaia di immobili. Nonostante questo si registra una certa resistenza ad utilizzare queste proprietà come residenza temporanee o a fini turistici. L’obiezione? Il rischio gentrificazione delle aree montane o delle aree interne. Come a dire: meglio abbandonate che sfruttate in altro modo.
Anche qui c’è da riscontrare un certo controsenso rispetto a molte obiezioni al Decreto Salva Casa. Servono più case in città, ma anche (e soprattutto) case più fruibili. Vedremo quindi come il Decreto verrà recepito (od osteggiato) a livello locale.
Stando ai dati, ci sono molte case non utilizzate anche nelle città con emergenze abitative
E le case inutilizzate permanentemente, secondo l’Istat, sono anche tante in città come Milano, dove su 810 mila case, 110 mila sono disponibili. Eppure il problema, dicono in molti, è l’utilizzo per gli affitti a breve che a Milano (stando a questi dati) non arrivano nemmeno al 2% dello stock e a poco più del 10% di quelle ‘disponibili’. Dati alla mano non si direbbe.
Nel corso degli ultimi decenni si è assistito a uno spostamento progressivo della popolazione dalle aree interne verso le zone del Paese, in cui sono presenti più servizi e più opportunità lavorative.
Da un lato nelle zone più attrattive ci si trova di fronte a vere emergenze abitative, data la scarsità di case disponibili. Dall’altra, nelle aree più distanti dai poli, ci sono strutture non abitate oppure sfruttate, raramente, come seconde case. e i servizi, oltre ad ottenere diverse entrate di tipo economico.
Ma quali sono le aree del Paese in cui ci sono più case non abitate?
Innanzitutto la rilevazione fa riferimento al concetto di abitazione permanentemente occupata, considerata come il luogo nel quale almeno un individuo ha la propria dimora abituale. Oltre alla rilevazione censuaria, è stato considerato dall’ente anche il registro statistico dei luoghi. Si tratta quindi di una integrazione tra la rilevazione censuaria e le fonti amministrative disponibili.
Inoltre è opportuno ricordare che tra le abitazioni non occupate in modo permanente sono incluse non solo le strutture disabitate ma anche le seconde case, aspetto importante soprattutto per le mete turistiche. Si tratta comunque di un indicatore interessante da considerare per valutare gli effetti dello spopolamento e della sovrappopolazione in certe aree del paese.
La presenza di abitazioni non permanentemente occupate è maggiore all’allontanarsi dai comuni centrali in termini di servizi. Le amministrazioni delle città principali ‘Polo’ riportano un’incidenza del 16,9%, a cui seguono quella dei poli intercomunali (23,3%) e dei comuni cintura (24,2%), tra i due valori non c’è una differenza particolarmente rilevante. Distanziandosi dai centri la percentuale aumenta in modo più consistente.
Incide anche la zona altimetrica in cui il comune è situato. In pianura l’incidenza è al 18,9%, crescendo al 26,2% nella collina interna. Montagna e collina litoranea riportano valori pari al 32% e al 33,1%. È però nella montagna interna che il fenomeno è più prevalente, con il 47% delle abitazioni presenti non occupate da almeno un dimorante abituale.
I dati sono un ottimo modo, se non l’unico, per analizzare fenomeni, raccontare storie e valutare pratiche politiche, come pure per rilevare moltissimi pregiudizi nelle pagine che si leggono su molti media e nelle parole di molti politici.